Schipario (Bergamo) - Diga del Gleno: incontri, concerti, eventi culturali e sportivi per commemorare il "Centenario del Disastro". In corso una ricerca multidisciplinare dell’Università degli Studi di Bergamo. Una canzone di Giorgio Cordini in ricordo delle vittime del 1923 e interpretata da Omar Pedrini, Cristina Donà, Enrico Bollero. Sono oltre 50 gli appuntamenti organizzati durante l’anno per commemorare il Centenario del Disastro del Gleno del prossimo 1° dicembre.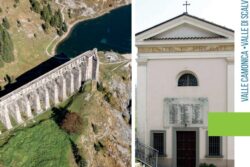
IL PROGRAMMA - Un fitto calendario di eventi, in partenza il 21 aprile con termine il 9 dicembre 2023, accompagneranno il pubblico in un lungo percorso di riscoperta e ricordo de «Il Disastro», evento che ha segnato profondamente la Val di Scalve e la Valle Camonica.
La proposta, sviluppata dal comitato Centenario Disastro Diga del Gleno, in coordinamento con enti ed istituzioni tra la Valle di Scalve e la Valle Camonica, ha ottenuto il Patrocinio della Provincia di Bergamo e della Provincia di Brescia, della Comunità montana di Scalve e della Comunità Montana della Valle Camonica, oltre che dai Comuni di Angolo Terme, Azzone, Colere, Darfo Boario Terme, Schilpario e Vilminore.
DISASTRO DEL GLENO - Per questi territori, la parola Disastro è indissolubilmente legata a quanto accadde il 1° dicembre 1923: alle 7.15 circa, una parte della diga, realizzata qualche anno prima, crolla e quasi 6.000.000 di metri cubi d’acqua si riversano nella vallata sottostante, provocando 359 vittime oltre a danni incalcolabili.
Il termine Disastro, oggi, ricorre in tutti i racconti della comunità scalvina e camuna, ripetuto di testimonianza in testimonianza, fino a diventare nome proprio, a racchiudere in poche sillabe la portata tragica dell’evento, i cui segni ancora oggi sono visibili sul territorio e nella comunità.
Per questo motivo la Commissione per il Centenario del Gleno ha scelto di utilizzare la parola Disastro nel logo che accompagnerà tutte le iniziative del 2023: per sottolineare l’impatto e il significato che il Gleno ebbe sulla storia, ma soprattutto sulle comunità e sulle vite delle due valli.
LA CANZONE - Per l’occasione, è stata lanciata la canzone “Viene giù il Gleno” di Giorgio Cordini, chitarrista e compositore già al fianco di Fabrizio De André e di alcuni fra i più importanti interpreti della musica italiana. Nell’anno del Centenario del Disastro del Gleno, l’artista, che vive in Val di Scalve, territorio profondamente segnato dal Disastro, ha voluto fare memoria di quel tragico evento e rendere omaggio al ricordo delle vittime, numerose anche nella vicina Valle Camonica. Il brano è eseguito coralmente, oltre che dall’autore, da altri tre interpreti della canzone italiana: Omar Pedrini, Cristina Donà, Enrico Bollero.
Inoltre, entro un più ampio quadro di collaborazione con le istituzioni locali, dal 2021 l’Università degli studi di Bergamo ha dato vita al progetto di ricerca “A partire da quel che resta. Il Disastro del Gleno tra storia e paesaggio, memoria e futuro (1923- 2023)”. I risultati dello studio, raccolti in un volume, saranno oggetto di presentazione e di confronto nel convegno programmato sabato 25 novembre, che si terrà presso la sede dell’Università degli studi di Bergamo.
I COMMENTI - Stefano Albrici, presidente comitato Centenario Disastro Diga del Gleno: "Inauguriamo oggi questo calendario di eventi che ci accompagnerà fino alla data del primo dicembre, dove tutte le comunità toccate dal Disastro del Gleno si uniranno per un evento commemorativo al quale arriveremo dopo un lungo percorso di lavoro e collaborazione. Mesi, durante cui abbiamo realizzato un progetto con attenzione e, soprattutto, con sensibilità pensando ad un programma ricco di storia, arte, cultura, sport e musica che potesse onorare quella che fu, forse, la prima tragedia “mediatica” d’Italia. A 100 anni dagli eventi, la Valle di Scalve e la Valle Camonica non dimenticano e vogliono rendere omaggio alle vittime di questo immane Disastro con la coscienza della responsabilità".
Emanuele Moraschini, presidente Provincia di Brescia: "Un Disastro che ha colpito le popolazioni delle province di Brescia e Bergamo, e che, drammaticamente, anticipò di quarant'anni quello del Vajont. È importante mantenere vivo il ricordo di quelle vittime innocenti, di quelle comunità sotto choc, che hanno dovuto trovare la forza di ricominciare a ricostruire tutto ciò che l’acqua, il fango e i detriti avevano portato via. Brescia e Bergamo unite in quella tragedia come nei momenti più drammatici della pandemia. Brescia e Bergamo ancora insieme, oggi, nella gioia di essere Capitale della Cultura, occasione unica per mettere in mostra il nostro grande patrimonio storico, artistico, enogastronomico e paesaggistico"
LA STORIA - Il 21 marzo 1907 viene presentata dall’avvocato Federici, per conto di Giacomo Trümpy, su progetto dell’ingegner Tosana di Brescia, la prima domanda di concessione per lo sfruttamento delle acque del Nembo e del Povo, con uno sbarramento su quest'ultimo alla piana del Gleno. Dopo altre istanze il 31 gennaio 1917 la ditta Viganò di Albiate di Triuggio (Milano), subentrata nella richiesta, viene autorizzata a costruire una diga con capacità di 3,9 milioni di metri cubi. Nel 1917/18 iniziano i lavori accessori quali tracciamenti, canali, strade, teleferica ecc. Nel 1919 cominciano gli scavi per la costruzione di una diga a gravità, su progetto dell’Ing. Gmür, con capacità di 5 milioni di metri cubi. che prevede l’uso della calce prodotta da un forno posto a fianco della centrale di Valbona. Nel 1920 si dà il via ai lavori per la realizzazione del cosiddetto “tampone” che sbarra nella gola la vallata: insieme alla calce vengono impiegati anche 9.240 quintali di cemento. In agosto muore l’Ing. Gmür e viene assunto definitivamente l’Ing. Giovan Battista Santangelo, palermitano, il quale mette a punto un progetto di diga ad archi multipli da impostare sopra al “tampone” che ormai ha raggiunto i 18-20 metri di altezza. Sarà l’unica diga al mondo con queste caratteristiche.
Nel 1921 la ditta Viganò avvisa il Genio Civile di Bergamo della variazione del progetto e, senza aspettare l’autorizzazione come da prassi errata ma corrente, incarica dei nuovi lavori l’impresa Vita e C. di Corbetta (MI) la quale, stando a numerose testimonianze di operai scalvini, opera in modo scorretto, frettolosamente e senza curarsi della qualità. Anche i materiali usati non sono sempre dei migliori e nei piloni finisce un po’ di tutto quindi nel muro della diga si verificano perdite, ricordate anche dal guardiano Francesco Morzenti. I lavori proseguono nel 1922 e nel 1923; la diga raggiunge per la prima volta la sua massima capacità il 14 ottobre 1923.
Il 1° dicembre 1923 alle 7.15 circa, la parte della diga costruita sopra il “tampone” crolla e quasi 6.000.000 di metri cubi d’acqua si riversano nella vallata sottostante. La fiumana, seminando dolore e morte, travolge Bueggio, il Dezzo, cinque centrali idroelettriche, Angolo con Mazzunno e Corna di Darfo per terminare la sua corsa nel fiume Oglio e poi nel lago d’Iseo. Le vittime innocenti, tra Valle di Scalve e Valle Camonica, sono ufficialmente 359, ma è probabile che ve ne siano state altre. Ingenti sono anche i danni materiali causati a privati, industrie e strutture pubbliche. Vengono organizzati comitati per aiutare i danneggiati ed il totale raccolto sarà di circa 4,5 milioni di lire.